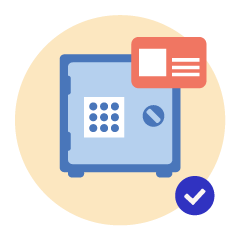La crisi demografica in Italia: dati e cause
I più recenti dati ISTAT del 2023 dipingono un quadro demografico che non può essere ignorato. La popolazione italiana oggi conta circa 58 milioni di abitanti e da tempo è entrata in una fase di profonda trasformazione. Il tasso di natalità ha toccato il minimo storico con appena 6 nascite ogni 1.000 abitanti, mentre i decessi si attestano a 11 ogni 1.000 abitanti. Solo grazie al contributo dell’immigrazione la popolazione totale riesce a restare sostanzialmente stabile.
Il rapporto tra pensionati e lavoratori attivi rappresenta uno degli indicatori più significativi per comprendere la sostenibilità del sistema previdenziale. Attualmente, in Italia ci sono circa 4 soggetti di 65 e più anni e 10 soggetti tra i 15 e i 64 anni (la cosiddetta forza lavoro), un rapporto già critico che sta peggiorando rapidamente.
Le proiezioni demografiche indicano che entro il 2050 il numero di anziani ogni 10 soggetti nella forza lavoro sarà superiore a 6, continuando a salire negli anni successivi. Ciò significa che se oggi ogni pensionato è sostenuto da almeno due lavoratori, in futuro tre lavoratori dovranno sostenere, con i propri contributi, almeno due pensionati.
La situazione è ulteriormente aggravata dal progressivo invecchiamento della popolazione: la fascia degli ultra 65enni, che oggi rappresenta circa il 24% della popolazione totale, raggiungerà il 34% entro il 2045. Contemporaneamente, la popolazione in età lavorativa (15-64 anni) si ridurrà significativamente, passando dall’attuale 63% a circa il 55% del totale.

L’impatto sul sistema pensionistico
Questi cambiamenti demografici non sono solo numeri astratti, ma hanno conseguenze concrete sul nostro sistema pensionistico.
Lo squilibrio generazionale sta diventando sempre più evidente: il numero di lavoratori attivi che sostengono con i loro contributi le pensioni in pagamento diminuisce progressivamente, mentre aumenta la popolazione pensionata.
A complicare ulteriormente il quadro contribuisce l’aumento dell’aspettativa di vita alla nascita, che oggi raggiunge gli 81,3 anni per gli uomini e gli 85,3 anni per le donne. Si stima una salita di tali valori di oltre 4 anni dei prossimi cinquanta. Ancora più significativa è l’analisi dell’aspettativa di vita per chi ha già raggiunto i 65 anni, ossia per i potenziali pensionati. Se oggi tale valore è pari a 19 anni e mezzo per gli uomini e 22 anni e mezzo per le donne, tra cinquant’anni questi valori dovrebbero salire di almeno 3 anni. Questo significa che il sistema previdenziale deve sostenere le prestazioni pensionistiche per periodi sempre più lunghi.


Il rapporto tra popolazione attiva e pensionata continuerà a deteriorarsi, mettendo ulteriore pressione sulla sostenibilità del sistema pensionistico pubblico. Questa tendenza non è una semplice fluttuazione temporanea, ma rappresenta un cambiamento strutturale della società, un processo ormai avviato non solo in Italia, ma in tutti i Paesi sviluppati, dove l’innalzamento dell’età pensionabile in relazione alla speranza di vita appare inevitabile (e, in Italia, previsto dalla normativa).
Perché la previdenza complementare è necessaria
In tale contesto, la previdenza complementare emerge come uno strumento fondamentale per garantirsi un futuro finanziario sereno. Non si tratta più di una scelta opzionale, ma di una necessità per mantenere un tenore di vita adeguato durante gli anni della pensione. La pensione pubblica, infatti, potrebbe non essere sufficiente a garantire il mantenimento dello standard di vita raggiunto durante gli anni lavorativi.
La previdenza complementare offre vantaggi significativi operando secondo un sistema a capitalizzazione, differenziandosi dal sistema a ripartizione tipico della previdenza pubblica. Mentre nel sistema a ripartizione i contributi dei lavoratori attivi finanziano direttamente le pensioni correnti, nella previdenza complementare ogni iscritto accumula i contributi versati, che vengono investiti sui mercati finanziari, generando rendimenti che si capitalizzano nel tempo.
Questo meccanismo, unito alla deducibilità dei contributi versati e a una tassazione agevolata, permette di costruire nel tempo un capitale attraverso un piano di accumulo personalizzato. Il sistema risulta così più sostenibile nel lungo periodo, poiché non dipende dal rapporto tra lavoratori attivi e pensionati, ma dalla capacità di generare rendimenti attraverso una gestione professionale degli investimenti.
La chiave per sfruttare al meglio la previdenza complementare sta nella pianificazione tempestiva. Iniziare a costruire il proprio futuro previdenziale fin dai primi anni di lavoro permette di distribuire lo sforzo contributivo su un periodo più lungo e di beneficiare maggiormente dell’effetto della capitalizzazione composta. La flessibilità nelle scelte di investimento consente inoltre di adattare la strategia alle proprie esigenze e al proprio profilo di rischio.
Con le novità introdotte dall’ultima legge di bilancio, inoltre, sarà possibile considerare anche la rendita della previdenza complementare per verificare il raggiungimento della pensione minima richiesta per chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996. Grazie al fondo pensione sarà possibile accedere al pensionamento anticipato laddove la pensione pubblica non sia sufficientemente elevata.
Il Gruppo AXA Italia non risponde dei contenuti degli articoli pubblicati